Alvaro e la Russia
In migliaia piansero la morte di Stalin, per molti fu la fine di un incubo. Alvaro seppe parlarne con una sensibilità che solo un russo poteva avere
I maestri del diluvio. Viaggio nella Russia Sovietica, pubblicato nel 1935, rappresenta un punto centrale nell’opera di Alvaro. Insieme a quello nella Germania nazista, il viaggio nell’Unione Sovietica stalinista avrebbe svelato ad Alvaro fino in fondo un sentimento che sarebbe diventato centrale in L’uomo è forte, la paura. Non la paura naturale, del dolore o della morte o di un pericolo reale, ma la paura come sistema, che cammina di pari passo con l’innaturalità dello sviluppo industriale e l’idolatria della tecnica, terribile divinità dell’uomo nuovo, elemento che accomuna sinistramente Nazismo e Stalinismo (e non solo).
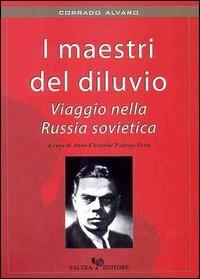
Così scriveva Alvaro: «La Russia è divenuta un enorme esercito di aspiranti alla tecnica, con una fede assoluta in essa, quasi che bastasse da sola a guarirla dai suoi mali secolari. La tecnica l’ha divisa di nuovo in classi, ha ristabilito le differenze. […] È il feticismo della tecnica». Questo fu un aspetto della società sovietica che Alvaro avrebbe notato in modo quasi ossessivo. E assai giustamente, dal momento che l’industrializzazione era il punto fondamentale della politica stalinista. Alvaro, però, non solo riuscì con grande acutezza a leggere tutto quello che la censura e il controllo cercarono di nascondergli, ma avvertì con profonda partecipazione la morte di un mondo antico che riconosceva in fondo vicino al suo, nel suo essere enormemente povero e vitale.
Nel suo viaggio lungo il Volga Alvaro visitò un mercatino di contadini kolchoziani:
Tutt’insieme quell’accolta di gente dava l’idea d’un tipo antico, ignaro, sopravvissuto, e le loro stesse merci parevano rinvenute in una vita profonda, appena scavata dalle rovine del turbine che aveva sconvolto la faccia d’un continente. […] Ecco dove s’era rifugiata la vecchia Russia. E il materialismo dialettico? E la tecnica? Questo, che era uno spettacolo di un forte color di terra, stava alle soglie della città operaia di Sòzgorod come un antico bassorilievo.
L’URSS che Alvaro avrebbe rappresentato non era disumana semplicemente per il regime che la governava con la violenza, e che aveva portato migliaia di contadini alla fame (Alvaro descrisse le vittime della carestia del ’34 con immagini indimenticabili nella loro essenzialità priva di retorica), ma lo era soprattutto per aver scelto la strada che in Russia i populisti avevano scartato, gli slavofili avevano rifiutato per principio, gli occidentalisti mitizzato, i socialisti criticato e nello stesso tempo adorato, quella dell’Europa borghese e capitalistica, che preferiva l’industria e la tecnica all’uomo.
[…] le fabbriche m’interessano, ma m’interessa assai più l’uomo. Che cos’è la civiltà se non l’uomo? La crisi ci ha insegnato qualche cosa, e il macchinismo americano anche di più. Non ci sono che i tempi magri per misurare bene il nocciolo delle civiltà. Ma i russi hanno messo tutto il loro onore nel fatto d’aver industrializzato il paese.
Alvaro fu cosciente che il “periodo romantico della rivoluzione proletaria” era già finito al momento dei suoi viaggi in Russia, e fu altrettanto consapevole che il paese del ’17 si andava sempre più borghesizzando. Ultimamente gli operai sovietici fecero una mozione per ottenere di poter lavorare coi guanti. Non è una cosa pulita il lavoro? Spero che i proletari non abbiano paura di sporcarcisi le mani; e che fra tanto parlare di burgiuà, di borghesi e di piccoli borghesi, non sia proprio la dittatura del proletariato a rendere borghese il lavoro.
Sebbene lo scrittore concluda la sua cronaca di viaggio con un’esaltazione della civiltà europea occidentale, e che qua e là questa esaltazione appaia anche discutibilmente (ma Alvaro pubblica in pieno Fascismo), l’eurocentrismo, che caratterizzava quasi tutti i suoi contemporanei che si occupavano della Russia e dell’URSS, non gli impedì, al contrario di questi ultimi, di essere obiettivo nel riconoscere progressi quali l’alfabetizzazione e l’emancipazione femminile.
E gli permise di essere lucido e partecipe nell’osservazione di un mondo che avrebbe potuto essere diverso e non lo era stato, e che infine aveva preferito il grigio alla poesia: Mi tornano a mente i gridi dei poeti negli anni terribili: “Non voglio i cieli senza le scale! – Non voglio che cada la neve! – Il mondo ha partorito un uovo solare!” I poeti finirono nel suicidio, qualcuna delle loro opere è proibita. Furono forse gli ultimi poeti religiosi della Russia, amavano la terra, insorsero in difesa di Cristo, sofferente in quel mondo di sofferenti. Il cervello di qualcuno di questi poeti è oggi in una boccia d’alcool all’Istituto del Cervello, e la nuova Russia materialista ne studia le involuzioni.
Gli intellettuali, come i contadini, in un regime tecnocratico che idolatrava la classe operaia perché funzionale allo sviluppo industriale, avevano perso il ruolo primario di coscienza popolare: il potere politico preme dall’alto coi suoi mezzi; la classe operaia, da cui si spera di trarre tutto il nuovo organismo intellettuale, spinge dal basso; nel mezzo si trovano gl’intellettuali, professionisti, artisti, tecnici, contadini, indispensabili ma tenuti in sospetto, ma del tutto impopolari.
In conclusione, Alvaro spinse la sua critica più lontano delle facili accuse di dittatura rivolte al regime stalinista, che presentava tratti a volte persino ingenui (ad esempio nel culto della personalità), e la rese più assoluta nella condanna della tecnocrazia e della sua disumanizzazione, che illusoriamente l’uomo moderno considera sinonimo di progresso.
Osservando i lavoratori della regione del Volga, scrisse: La fatica qui è rimasta fatica, ed ecco una cosa per cui gli uomini erreranno da illusione a illusione, perché dalla fatica non ci libererà mai nessuno. […] L’arcangelo che liberi l’uomo dal lavoro duro non è venuto e non verrà mai, e le rivoluzioni che promettono il paradiso sono inebrianti per pochi giorni, il tempo in cui l’umanità si prende una vacanza prima di tornare alle sue leggi.
Credo che sia difficile trovare parole più giuste e umane per descrivere il fallimento della Rivoluzione d’Ottobre nella sua essenza, quella di essere un’utopia che, come credevano i populisti, poteva diventare realtà nell’unico paese che non aveva conosciuto davvero il mondo borghese e le sue leggi. E che invece, non diversamente dalla Germania nazista, dall’America capitalista e dagli altri paesi europei, decretava la fine di un mondo antico e naturale per rincorrere i falsi miti del meccanicismo.
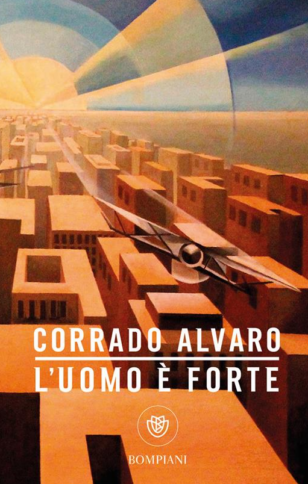
In L’uomo è forte, romanzo del 1938, Alvaro continua a narrare l’Unione Sovietica. Ma questa voltail tema principale non sarà quello dell’industrializzazione e della tecnocrazia, ma della loro compagna, che le segue come un’ombra, indispensabile elemento perché le rivoluzioni dall’alto si adempiano – la paura.
Il protagonista del romanzo, Roberto Dale, è un ingegnere (figura emblematica di un regime che idolatra la tecnica). Come accadde realmente negli anni Venti e Trenta, Dale torna nel suo paese (che nel romanzo non ha nome) perché crede agli ideali della rivoluzione. Lì incontrerà un amore giovanile, Barbara, e inizierà con lei una storia che da subito si rivelerà impossibile, condannata in modo oscuro e nello stesso tempo evidente da un sistema che non può accettare l’incontro tra uno straniero e una sua cittadina (com’era nella realtà in Unione Sovietica). Dale rappresenta l’estero, personificazione d’ogni male, e quindi porta questo male dentro di sé, coinvolgendo in esso anche chi gli sta accanto e lo ama. Alla fine, confessando delitti mai compiuti, Barbara denuncerà Dale all’Inquisitore, per liberarsi di un incomprensibile senso di colpa e di pericolo insieme. Dale fuggirà, sarà catturato dai Partigiani (l’esercito rivoluzionario) e verrà quasi ucciso. Si sveglierà in un ospedale, rispettato e curato come vittima delle Bande, l’esercito controrivoluzionario. Un equivoco vero o l’ennesimo inganno? Dale non sembra volerselo chiedere, inizia già a progettare un nuovo piano di fuga. Anche se il medesimo Alvaro, dopo la Liberazione, volle avvertire che il suo romanzo aveva come tema la paura che accompagna ogni regime dittatoriale, Fascismo e Nazismo inclusi, è assolutamente evidente che L’uomo è forte sia fondato sull’esperienza fatta dallo scrittore in Unione Sovietica. La paura di cui parla era sì comune anche al Nazi-fascismo, e funzionale a un regime dittatoriale, ma aveva una natura diversa, perché aveva radici ideologiche diverse.
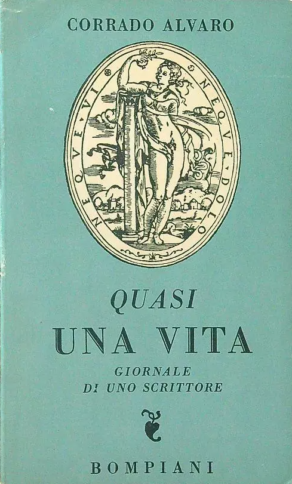
In Quasi una vita Alvaro scrisse a proposito del suo arrivo a Berlino, al ritorno dalla Russia: All’albergo di Berlino, nella città notturna, la paura, ma questa volta non una paura arcana, bensì qualcosa di crudele. […] Nella vostra paura, in Russia, diventavate voi stesso ai vostri occhi un personaggio importante e misterioso; nella paura a Berlino, eravate un essere trascurabile, un insetto, uno che vive per caso o per distrazione.
La paura che il regime stalinista usava come sistema di controllo aveva un tratto, per così dire, più nobile. Ed il perché ce lo spiega il dialogo tra Dale e l’Inquisitore, dialogo che ricorda in modo straordinario un monologo (senza dubbio ben noto ad Alvaro), quello del Grande Inquisitore in I fratelli Karamazov di Dostoevskij. Lo scrittore russo immagina il ritorno di Cristo nella Siviglia del Cinquecento e il suo arresto per opera del Santo Uffizio: Le guardie conducono il prigioniero nella tetra prigione a volte nell’antico palazzo del Santo Uffizio e ve lo rinchiudono. Il Grande Inquisitore, che ha ordinato l’arresto, dice a Cristo che lo brucerà come un eretico, perché la sua presenza è un pericolo – la libertà che ha regalato agli uomini li ha resi infelici. Anziché impossessarti della libertà umana tu l’hai potenziata e hai oppresso per sempre con il fardello dei suoi tormenti il dominio spirituale degli uomini.
Per renderli di nuovo felici, lavorando e sacrificandosi per questo, l’Inquisitore e i suoi compagni toglieranno la libertà agli uomini. E così Dostoevskij prefigura una società che, da slavofilo e ortodosso, non poteva che identificare con quella cattolica e occidentale, la cui condanna era anche un’ammonizione, affinché la Russia si salvasse da essa.
Paradosso della storia, le parole di Dostoevskij sono profeticamente il ritratto del regime stalinista che Alvaro descrive con uguale potenza in L’uomo è forte: [..] noi li convinceremo che saranno liberi soltanto quando rinunceranno alla loro libertà in nostro favore e si assoggetteranno a noi. […] Sì, li costringeremo a lavorare, ma nelle ore libere dalla fatica organizzeremo la loro vita come un gioco infantile, con fanciulleschi cori e canti e danze innocenti. […] Diremo loro che ogni peccato, purché commesso con il nostro consenso, verrà riscattato; che concediamo loro di peccare perché li amiamo e che il castigo per questi peccati lo prenderemo su di noi. Lo prenderemo su di noi ed essi ci adoreranno come benefattori perché ci saremo fatti carico dei loro peccati dinanzi a Dio. E non avranno più segreti per noi.[…] Tutti, proprio tutti i segreti più angosciosi della loro coscienza li porteranno da noi e noi li risolveremo, ed essi si rimetteranno con gioia alla nostra decisione perché ciò li libererà da un grande affanno e dalla terribile attuale sofferenza di dover decidere da sé. E tutti saranno felici, milioni di esseri, fuorché quel centinaio di migliaia che saranno alla loro guida. Perché solo noi, noi che siamo depositari del segreto, saremo infelici.
Questa è la grande differenza tra un’ideologia come quella nazista o fascista e quella sovietica. Nelle prime due non viene promessa la felicità per tutti, tutt’al più l’eroismo per pochi. Ma pensare che la felicità di tutti si possa realizzare dall’alto, privando l’uomo del suo unico anche se problematico bene, la libertà, non è meno terribile della mitizzazione dell’eroismo guerriero e individualista, anzi, lo è ancora di più. Alvaro ripropone la figura dell’Inquisitore (nome che veniva dato in effetti a chi interrogava i prigionieri durante le repressioni staliniste) pensando forse non solo a Dostoevskij e alla realtà sovietica che aveva conosciuto, ma anche al suo conterraneo Campanella. In effetti, proprio come un inquisitore del Santo Uffizio, il personaggio di Alvaro dimostra di volere la salvezza delle sue vittime (con questo atteggiamento accoglierà Barbara che andrà a denunciare Dale) giustificando così la violenza del suo potere. E Dale capirà ancor meglio proprio da lui (come Campanella o Bruno dai loro torturatori) quanto valga la sua libertà, la sua indipendenza di pensiero, il suo essere, in altre parole, un uomo.
Dale conoscerà l’Inquisitore per strada, subito dopo essere scampato all’investimento di un tram che, forse, non era così accidentale. E lo seguirà, ignaro, nel suo ufficio, dove, non diversamente da quello dostoevskiano, l’Inquisitore alvariano spiegherà allo stupito ingegnere il senso di quella paura che lo ha seguito da quando è tornato nel paese della Rivoluzione.
Noi […] vogliamo che i nostri cittadini siano felici. Devono essere felici per forza. […] Tutto quello che li turba è delittuoso. Essi hanno la verità, la giustizia, la felicità. Essi non hanno misteri. […] Non si devono nascondere nulla. Il mondo intero deve essere pulito, senza ombre, senza dubbi, senza segreti, senza veleni di desiderii e di nostalgie. […] Bisogna distruggere tutto quello che è privato, personale, intimo, e che è la causa di tutti i mali di cui soffre oggi l’umanità. Avere un segreto è un delitto! […] Noi siamo uno strumento. Niente altro che uno strumento di un’umanità migliore. Noi siamo le vittime. Cadremo l’uno dopo l’altro. Ed è giusto. Mi macchierò anch’io un giorno di un delitto. Sarà tempo di scomparire. Ma intanto, avrò giovato anche coi miei delitti.
L’Inquisitore alvariano, come quello dostoevskiano, dunque, non solo giustifica, ma addirittura santifica la sua missione, attuando quello che proprio l’autore de I fratelli Karamazov aveva indicato come il peggiore dei crimini, la giustificazione del delitto per la giustezza di una causa. In questo Alvaro riesce mirabilmente a fondere il pensiero dostoevskiano con la realtà della mistica della Rivoluzione che negli anni Trenta portò al culto della personalità di Stalin.
Roy Medvedev, storico russo che con Sacharov fece parte degli intellettuali che criticavano da sinistrail regime sovietico, scrisse a proposito degli anni immediatamente precedenti a quelli del culto della personalità: Per quanto il culto di una singola persona non fosse ancora apparso, si poteva egualmente assistere al nascere di un culto per concetti quali il partito, lo Stato sovietico, la rivoluzione, il proletariato. Agli iscritti veniva inculcata la convinzione che il partito nel suo insieme non poteva commettere sbagli, che il partito sapeva ogni cosa. Non dovevano esserci segreti per il partito, neppure quelli di natura più intima; gli si doveva rivelare tutto, come a Dio in confessione. Un comunista doveva essere pronto a compiere qualsiasi cosa al servizio del partito e dello Stato; la rivoluzione giustificava ogni crudeltà.
Questa, forse, fu l’atrocità maggiore dello Stalinismo, quella di costringere milioni di persone a vivere in un clima di paura nel quale sospetto, controllo e delazione diventarono abitudine e sistema di vita, a tal punto da essere addirittura una certezza necessaria, una fede. Migliaia di russi piansero sinceramente la morte di Stalin, come nel passato avevano fatto con gli zar. Avevano davvero creduto che la sofferenza che avevano patito fosse ricambiata dal potere con la serenità che dà chi si sacrifica per noi. Ma in molti, ovviamente, la salutarono come la fine di un incubo, anche se il senso della paura arcana e onnipresente che avevano conosciuto sarebbe stato ancora per molto tempo una presenza nella loro vita. Alvaro seppe dire tutto questo con una sensibilità che solo un russo poteva avere. E con un rispetto e un amore verso un popolo e una storia, che pure non erano i suoi, che riflettono una capacità di universalità etica assai rara in anni in cui non si dava troppo peso alla vita umana.
E questa sua capacità è anche la maggiore prova di quanto la Russia e la sua cultura fossero penetrate in lui, con tutte le loro contraddizioni e la loro umanità, paradossale e forte. Come l’uomo, che non finisce di essere tale fino a quando non permetterà a nessun inquisitore di decidere per lui ciò che è bene e ciò che è male. Fino a quando preferirà la fuga alla tranquillità regalata dalla paura.
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

L'offerta informativa del Corriere della Calabria rimarrà gratuita
Senza le barriere digitali che impediscono la fruizione libera di notizie, inchieste e approfondimenti. Se approvi il giornalismo senza padroni, abituato a dire la verità, la tua donazione è un aiuto concreto per sostenere le nostre battaglie e quelle dei calabresi.
La tua è una donazione che farà notizia. Grazie
P.IVA. 03199620794, Via del mare 6/G, S.Eufemia, Lamezia Terme (CZ)
Iscrizione tribunale di Lamezia Terme 5/2011 - Direttore responsabile Paola Militano | Privacy
