Alberto Prunetti: «Racconto la storia di chi si è ribellato, senza piegarsi, al regime fascista»
“Troncamacchioni” tra le opere in concorso al Premio La Cava. L’autore: «Ho cercato di far parlare le carte d’archivio»

Una storia ambientata nella Maremma di inizi Novecento, sullo sfondo il periodo in cui il fascismo ha iniziato a mettere radici profonde. Troncamacchioni (Feltrinelli) racconta lo spirito ribelle di minatori e contadini che non hanno niente da perdere ma che non rinunciano a opporsi, «persone del popolo abituate da generazioni a piegarsi davanti alla volontà dei signori», ma che «per le circostanze della storia, si trovarono costrette a ribellarsi e poi a fuggire, inseguite dalle autorità del regime fascista. E lo fecero a testa alta, senza piegarsi». Un lavoro di ricerca anche storica, quella di Alberto Prunetti, scrittore e traduttore. «Adoro le figure che hanno fatto un lavoro culturale, letterario e politico in ambiti difficili, come la provincia e il Meridione. Io stesso vengo da una zona di provincia. E la Maremma era una zona che in Toscana aveva caratteristiche simili a quelle del Meridione», ci racconta l’autore dell’opera che ha conquistato un posto tra le dieci proposte al Premio Letterario “Mario La Cava”.
Già il titolo è evocativo di qualcosa, qual è il significato del termine “Troncamacchioni” e come si collega alle vicende che racconta?
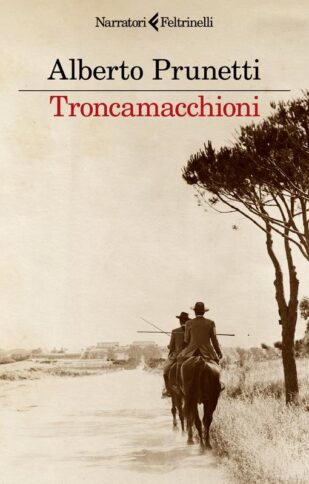
“Troncamacchioni” è un termine vernacolare del gergo dei carbonai e dei boscaioli delle Colline Metallifere, una zona mineraria della Toscana meridionale. Indica l’atteggiamento di chi si muove nei boschi con forza, quasi con prepotenza, aprendosi con determinazione un sentiero nonostante le avversità della natura spingano a piegarsi se non ad arretrare. In senso lato, uso questo termine per raccontare la storia di un gruppo di braccianti e di minatori, persone del popolo abituate da generazioni a piegarsi davanti alla volontà dei signori, che ai primi lustri del Novecento, per le circostanze della storia, si trovarono costrette a ribellarsi e poi a fuggire, inseguite dalle autorità del regime fascista. E lo fecero a testa alta, senza piegarsi.
E’ stato difficile raccontare un periodo così delicato e complesso dal punto di vista storico?
Non è di per sé difficile raccontare il fascismo o un’altra pagina della storia italiana, il punto è riuscire a farlo bene. Nel mio racconto ho cercato di far parlare le carte d’archivio. Carte scritte però da quelle stesse autorità del regime fascista che volevano punire, sorvegliare e castigare i protagonisti dei miei libri. Quindi i miei analfabeti eroi sono le vittime anche delle carte d’archivio con cui ho ricostruito le loro storie. Pertanto ho dovuto vagliare quei documenti, interpretarli, senza considerali per forza una verità storica.
Influisce nella sua scrittura, in qualche misura, il suo lavoro di traduttore?
Sono due lavori molto simili, eppure completamente diversi. Sono entrambe forme di autorialità: infatti nella catalogazione bibliografica la voce “traduttore” è una voce autoriale e in teoria la legge impone di pagare il lavoro dei traduttori con le royalties e i diritti d’autore. Mentre traduco, però, sono vincolato alla scrittura del testo da un’altra opera e non posso scrivere con la libertà dell’autore. Sono a servizio di un testo, di un testo che come autore magari scriverei in maniera diversa, ma che come traduttore non posso riscrivere. Insomma, il lavoro e il destino dell’autore e del traduttore sono diversi. Inoltre mentre la figura dell’autore viene spesso promossa ai limiti del narcisismo, la figura del traduttore è condannata all’invisibilità. Sono quindi due posture diverse. A me piace molto la figura dell’autore/traduttore, ossia la figura di chi sovrappone questi due piani nella propria attività professionale, senza però confonderli, occupando due funzioni diverse nell’economia dell’industria del libro. In questo senso mi ritrovo paradossalmente a camminare sullo stesso sentiero calcato, con le sue scarpe pesanti da contadino, da Lucianone Bianciardi: ossia ribaltare parole da una lingua a un’altra per cinque giorni alla settimana e nel tempo del weekend scrivere i miei romanzi. Sono ambiti separati ma che camminano paralleli e la traduzione è un grande esercizio di scrittura.
La sua opera è tra le dieci proposte al Premio Letterario “Mario La Cava”, dedicato a uno scrittore che ha raccontato con dovizia di particolari storie e contesti storici emblematici, si pensi a “I fatti di Casignana”. Ne è contento?
Ne sono entusiasta. Adoro le figure che hanno fatto un lavoro culturale, letterario e politico in ambiti difficili, come la provincia e il Meridione. Io stesso vengo da una zona di provincia. E la Maremma era una zona che in Toscana aveva caratteristiche simili a quelle del Meridione. Ad esempio, mentre il contado senese e quello fiorentino avevano una struttura agricola improntata alla mezzadria, in Maremma ancora nel Novecento e fino alla riforma agraria postbellica, vigeva il latifondo, con grandi proprietari assenteisti che praticavano forme di allevamento brado del bestiame. Non stupisce quindi che in Maremma fosse radicato il fenomeno del brigantaggio, come nel Meridione. Infine per me è molto interessante la lezione di Rocco Scotellaro, un intellettuale di origine contadina e proletaria che ha fatto inchiesta sui gruppi subalterni del Meridione in un progetto editoriale voluto da Vito Laterza. Laterza negli anni Cinquanta ha commissionato a intellettuali prossimi al mondo popolare delle forme di inchiesta narrativa, un ciclo che prevedeva, oltre che Contadini del sud (Laterza, 1954), anche I minatori della Maremma di Bianciardi e Cassola (Laterza, 1956)) e Operai del nord di Edio Vallini (Laterza, 1957). E proprio l’opera di Bianciardi e Cassola è il testo che più mi ha motivato a scrivere Troncamacchioni. E non stupisce quindi che possa innescarsi un legame tra il mio lavoro di scrittura e il Premio La Cava, considerato l’impegno di Mario La Cava nel raccontare ne I fatti di Casignana il mondo dei subalterni delle campagne calabresi in contrasto con i grandi possidenti della proprietà agraria.
L’autore
Alberto Prunetti (Piombino, 1973) è autore di Amianto. Una storia operaia (disponibile in “Universale Economica” Feltrinelli), 108 metri, Nel girone dei bestemmiatori e Non è un pranzo di gala. Indagine sulla letteratura working class. Traduttore e redattore editoriale, dirige la collana Working class di Alegre e il Festival di Letteratura Working Class.
Il premio letterario “Mario La Cava”
Giunto alla sua ottava edizione, il Premio letterario “Mario La Cava” ha visto negli anni precedenti il trionfo di scrittrici e scrittori come Claudio Magris, Maria Pia Ammirati, Nadia Terranova, Donatella di Pietrantonio, Alessandro Zaccuri Gian Marco Griffi, Maria Grazia Calandrone.
Ogni anno viene assegnato a illustri personaggi del mondo letterario il Premio Speciale “La Melagrana” (negli anni precedenti Raffaele Nigro, Raffaele La Capria, Walter Pedullà, Piero Bevilacqua, Luigi Maria Lombardi Satriani, Massimo Onofri, Salvatore Silvano Nigro).
Nel corso della prossima edizione, così come negli anni precedenti, sarà poi assegnato il Premio dei lettori del Caffè, scelto tra i libri in gara da una giuria composta da appassionati lettori.
Le opere in concorso
Le opere proposte da una commissione composta da critici e scrittori tra quelle pubblicate in Italia nel 2024, saranno valutate da una giuria composta da Andrea Carraro, scrittore, Arnaldo Colasanti, critico e scrittore, Alessandro Moscè, critico e poeta, Caterina Verbaro, docente di letteratura all’Università LUMSA di Roma, e Pasquale Blefari, assessore alla Cultura del Comune di Bovalino, che selezionerà la terna finalista. L’opera vincitrice, a cura della stessa giuria, sarà designata durante la cerimonia di premiazione che si terrà a Bovalino ad aprile 2025.
• Nostra signora da Messina – Eliana Camaioni – Algra Editore – Proposto da Paola Radici Colace
• Sparring partner – Andrea Caterini – Editoriale Scientifica – Proposto da Domenico Calcaterra
• Missitalia – Claudia Durastanti – La nave di Teseo – Proposto da Margherita Ganeri
• Il figlio di Forrest Gump – Angelo Ferracuti – Mondadori – Proposto da Marino Magliani
• Il fuoco che ti porti dentro – Antonio Franchini – Marsilio – Proposto da Maria Grazia Calandrone
• Certe sere Pablo – Gabriele Pedullà – Einaudi – Proposto da Salvatore Silvano Nigro
• La ragazza eterna – Andrea Piva – Bompiani – Proposto da Stefano Ercolino
• Troncamacchioni – Alberto Prunetti – Feltrinelli – Proposto da Marco Gatto
• Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia – Michele Ruol – Terrarossa – Proposto da Dario Ferrari
• I giorni di vetro – Nicoletta Verna – Einaudi – Proposto da Sandro Abruzzese
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

L'offerta informativa del Corriere della Calabria rimarrà gratuita
Senza le barriere digitali che impediscono la fruizione libera di notizie, inchieste e approfondimenti. Se approvi il giornalismo senza padroni, abituato a dire la verità, la tua donazione è un aiuto concreto per sostenere le nostre battaglie e quelle dei calabresi.
La tua è una donazione che farà notizia. Grazie
P.IVA. 03199620794, Via del mare 6/G, S.Eufemia, Lamezia Terme (CZ)
Iscrizione tribunale di Lamezia Terme 5/2011 - Direttore responsabile Paola Militano | Privacy
